Identità e intimità
Le vie del piacere
6 Ottobre 2014Al limite: sessualità e Aids
6 Ottobre 2014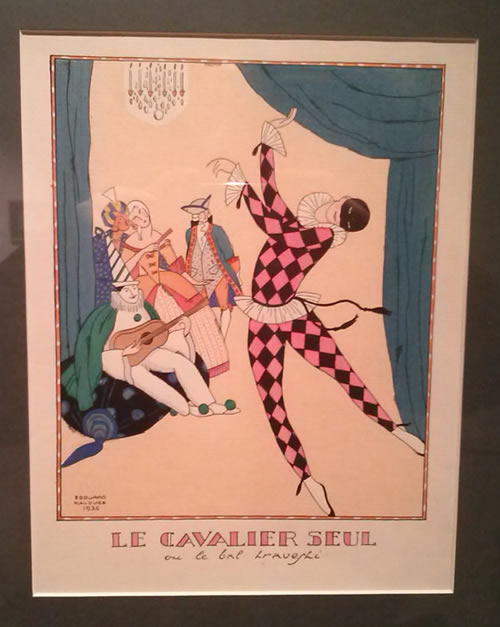
Identità e Intimità
"Così dobbiamo incontrarci divisi tu là – io qui – la porta appena socchiusa e tra di noi l’oceano – e la preghiera e il bianco nutrimento della disperazione – " (Emily Dickinson, n. 640, 1862)
La questione dell’identità è alla base delle modalità di contatto interpersonale e quindi dei rapporti d’intimità. Pertanto, è fondamentale interrogarsi sulle proprie capacità di entrare in relazione con gli altri, perché, se ci si concentra solo sui dettagli della vita sessuale, si rischia di applicarsi alla coltivazione dell'orto trascurando di edificare la casa in cui abitare.
L’identità è anzitutto una forma di intimità con se stessi, fondata sulla decisione di strutturare la propria personalità intorno ad un «centro» voluto consapevolmente.
Il patrimonio che ci si trova ad avere dal punto di vista sessuale e affettivo può essere vissuto come una fatalità cui adeguarsi o rassegnarsi, ma ciò non corrisponde ad un’identità, un’identità scelta; il che non vuol dire che si scelga in senso letterale, che si abbia libertà di scelta, si può soltanto prendere atto del potenziale naturale e organizzare un lavoro di appropriazione, allo scopo di svilupparsi e crescere.
Da questo rapporto con se stessi discende necessariamente ogni genere di scambio con gli altri. È impossibile essere onesti con le altre persone rimuovendo la domanda sulla propria identità, su chi sono io e cosa voglio da me, cosa so della mia interiorità e della mia dotazione costituzionale, tenendo conto del contesto affettivo in cui sono cresciuto, la famiglia, la società e l’ambiente culturale.
Il tempo dedicato a entrare in intimità con se stessi è quello necessario ad assumere pienamente e responsabilmente il mandato dell'esistenza, nonché a confrontarsi con gli altri con propositività.
Basta dare uno sguardo alla letteratura sull’argomento per rendersi conto che, pur in modo mascherato, gli scambi sessuali e sentimenti di fatto sono delle guerre dissimulate. Nel caso della sieropositività siamo alla lettera, nel senso che la guerra diventa microbiologica, c’è il rischio di una vera e propria distruzione dell’altro, non più soltanto ideale o fantastica, bensì concreta, e non c’è nulla di più grave dell’attentare all’identità biologica di un essere umano.
Ciò non vuol dire che ci sia sempre consapevolezza nel contagio, ma c’è da tener presente che la ricerca di fusione psicologica o emotiva può annientare e nel caso dell’Aids rischia di esitare in distruzione pura. Se il binomio «amore e morte» ha un suo fascino letterario, nella vita è accettabile solo quando riduce la morte, non quando la aumenta.
Se una persona si offrisse di morire al posto di un’altra, potremmo comprenderlo. Per numerose coppie miste per l’Hiv, invece, è lecito parlare di «associazioni a delinquere». Manca sovente qualsiasi ragionamento o discorso sul legame e su ciò che si intende condividere, nonché a quali condizioni.
Nelle relazioni interpersonali, infatti, si sta sempre ad alcune condizioni, l’amore è possibile a qualche condizione per gli adulti, perché è senza condizioni solo nel rapporto tra genitore e bambino o nella totale dedizione al prossimo. Tra adulti l’amore prevede sempre dei «contratti», che andrebbero stipulati il più possibile esplicitamente, non lasciandoli al caso o nell’ambiguità.
In tante coppie non c’è disponibilità a mettere in conto l'alterità, compreso l’aspetto della trasmissione di infezioni, il che porta ad un aumento della possibilità di malattia e di disagio, quindi a un’amplificazione del carico di morte (già sufficiente nella vita di chiunque), non a una riduzione come ingenuamente molti credono.
Pochi sono disposti ad accettare che il piacere sia «a pagamento» e abbia sempre «un prezzo», benché non nel senso masochistico della nevrosi o di certo cattolicesimo spicciolo. C’è un corrispettivo di lacrime per ogni ora di estasi e la moneta sonante riguarda il piano psicologico ed esistenziale: « Avete mai detto sì ad una semplice gioia? Oh amici, allora avete detto sì anche a tutto il dolore » (Nietzsche, Così parlò Zarathustra).
Occorre prender coscienza di quanto costi organizzare e volere la propria vita. Sorprende constatare quanti esercitino la sessualità senza volerla, senza aver mai riflettuto su ciò che fanno; altrettanto sconcertante è la povertà comunicativa nei contatti sessuali.
Le persone si limitano a praticare, a «fare», la sessualità rimane un territorio separato dal resto della personalità in cui si agisce in un dato modo senza neppure sapere perché.
A volte si dice che nel sesso ci si comporta in modo «bestiale», ma non è affatto vero, semmai sarebbe più corretto dire «disumano», perché gli animali hanno un comportamento sessuale molto diverso dal nostro.
Questa specie di area cieca rimane immutata per anni, anche fino alla vecchiaia, senza che avvenga mai l’integrazione con il resto delle aree della personalità. In quanto disgiunta, essa rischia di diventare una terra di nessuno, perché in mancanza di una coscienza non esistono colpe o responsabilità.
Sicché, si agisce fatalmente e in maniera fatalistica per istinto, per bisogno, perché lo vuole la natura, con il fine di ottenere sensazioni di benessere, rassicurazioni, molteplici esigenze di cui l’individuo è in sostanza vittima, dato che si limita all’esecuzione.
Chi ritiene di provare un desiderio si adopera per soddisfarlo, senza cercare di capire se sia compatibile con il progetto esistenziale. Eppure, il contenuto dei desideri sessuali rivela, quasi come una cartina di tornasole, tutte le cicatrici dello sviluppo e della storia personale. Attraverso il sesso e gli affetti noi diciamo tutta la fatica di star al mondo e tutta la mancanza di amore, per esempio, sperimentata nelle relazioni principali.
Affinché la sessualità possa generare qualcosa di «buono», di cui poter essere soddisfatti, e non solo dal punto di vista fisico, deve essere voluta, è necessario che il soggetto affermi la sua specificità, decidendo di riflettere e di comprendere il significato della propria sfera sessuale.
C’è bisogno perciò di un’identità, che ci sia, benché possa sembrare un termine improprio, un padrone di casa che abiti il corpo, la mente, la vita, e scelga di fare il proprio interesse in generale e non nel particolare. Nella sessualità, in effetti, si segue perlopiù l’interesse parziale, quello della gratificazione del bisogno, il che molto spesso non coincide con il benessere complessivo e può procurare notevoli svantaggi o addirittura mettere il soggetto in condizione di perdere la propria identità, sia in senso psicologico che in senso culturale.
La terra di nessuno della sessualità è un luogo dove alla fine tutto è permesso perché non c’è consapevolezza e non c’è responsabilità. Per questo il diritto alla sessualità degli ultimi decenni è in gran parte un equivoco. Si crede che possa esistere un diritto a mettere in pratica trascurando la componente del dovere, prima di tutto verso se stessi. Si pensa che poter arrivare all’esercizio sia il massimo consentito e il massimo a cui si possa aspirare, che sia più importante esercitare rispetto al volere.
È chiaro, invece, che quando si decide di avere una vita sessuale si deve avere il coraggio di scegliere i propri gesti sessuali selezionando tra quelli che paiono naturali e spontanei quali elaborare e far crescere, perché la sessualità è come una pianta da coltivare che ha bisogno di molta pazienza, amore e attenzione, giusto il contrario di quello che normalmente si fa.
Di solito c’è una disattenzione spaventosa per la propria vita erotica e affettiva, perché si presume che debba venire da sé e sia un fatto fisiologico, una sorta di congegno automatico. Purtroppo, ciò che va da sé sono i riflessi condizionati generati dalla matrice di complessi, conflitti e nevrosi individuali.
Bisognerà pur rendersi conto che parliamo di un contesto in cui la malattia è la norma e non l’eccezione, e non nel senso della follia da ricovero, bensì come disagio e disturbo nel rapporto con se stessi, sovente con un carico di gravi ferite patite nella costruzione dell’identità.
C’è chi pensa di poter guarire con un’operazione di rieducazione superficiale o di apprendistato, che si tratti di pseudo-comunità gay o di centri di recupero per tossicodipendenti; ci si aspetta che i comportamenti normalizzanti appresi in poco tempo facciano superare l’abisso del disagio da cui la persona proviene e in cui rischia di ritrovarsi regolarmente dopo essere passata attraverso diverse esperienze di socializzazione, soprattutto se c’è di mezzo l’Hiv.
La questione della malattia è determinante, perché riguarda proprio l’identità, chi siamo realmente, non quello che vorremmo essere, poiché possiamo partire solo da ciò che siamo; fosse anche un piccolo pezzetto, è importante che lo si pensi in termini di «malattia».
Prima di volere la salute bisogna capire bene dov’è e cos’è la malattia, altrimenti si finisce per credere che la propria storia sia un insieme di casualità, fatalità e circostanze sulle quali non si è avuto alcun potere e quindi non si capisce perché se ne dovrebbe avere in seguito.
Il problema della responsabilità dei propri gesti riguarda sia quelli che si sono subiti sia quelli del futuro; perciò, o c’è una responsabilità, insieme a un destino, nel passato oppure non ce ne sarà neppure nel futuro. Applicarsi a capire bene la propria malattia e riconoscerla fino in fondo, traendone tutte le conseguenze, è al contempo dovere e diritto non soltanto per chi ha problemi psicologici o sociali, ma anche per coloro che fanno gli operatori e i volontari, malati e a rischio da un altro punto di vista.
Si dice spesso, infatti, che lavorare con persone che stanno male fa stare bene, perché è assicurata almeno una consolazione grazie al paragone con chi sta peggio. Occorre sapere fino a che punto si è malati e di che cosa si è capaci.
Se ci sono ferite riguardo al sentimento, dovute alla carenza d’amore o ad una modalità sbagliata d’amare, se nell’interiorità c’è un vuoto oppure un pieno di cose negative, il minimo che ci si possa aspettare è un atteggiamento predatorio nei confronti degli altri e la ricerca per tutta la vita di un «risarcimento».
Proprio la sete di risarcimento porta a ridurre in miseria l’esistenza; chi è affamato di amore quando si avvicina a qualcuno in genere tende ad azzannarlo, punta alla sua gola dicendo che punta al suo cuore, e se mostra i denti non sorride.
Non si tratta di criminalità intenzionale, bensì di criminalità potenziale latente o patente in ogni persona che ha sofferto, perché non bisogna farsi illusioni o millantare sulle buone intenzioni del sentimento. Chi è affamato di amore tende a «cibarsi» di chi gli capita accanto, e del resto sarebbe incomprensibile il contrario.
Senza aver preso pienamente coscienza di cosa sia tale «fame», una mancanza posta nelle viscere e non nel cuore, è impensabile che si strutturino relazioni affettivamente paritetiche o paritarie. Non ci può essere parità dove non esiste identità. Dove non esiste un soggetto che si sia riconosciuto e definito in termini di diritti e doveri, è impossibile che ci sia reale parità o almeno una parità costruttiva e produttiva.
Le relazioni con gli altri dovrebbero aiutarci a star meglio, a migliorare la nostra capacità di sopravvivenza, altrimenti non fanno che aumentare la difficoltà di stare al mondo. Non conviene lasciare andare da sé le vicende relazionali, cioè occorre aspirare al bene, il che implica conoscere a sufficienza il male.
La negatività ha due forme: il male e la sofferenza. Il male è il negativo che vuole se stesso, che si riproduce di continuo (in psicoanalisi si parla di coazione a ripetere). È il negativo che non si è capito e che continua a ripresentarsi incessantemente, benché sotto aspetti diversi, per tutta l’esistenza.
Si passa perciò da un’esperienza negativa a un’altra, da situazioni in cui si subisce violenza (fisica o morale) ad altre in cui la si agisce sugli altri, perché il cerchio deve compiersi. Il male è il negativo che apre e chiude il ciclo infernale dell’agire e subire violenza. La sofferenza è la negatività che tende a trasformarsi in positività attraverso l’espiazione, per il modello cristiano, o attraverso la responsabilità, nel modello filosofico, in ogni caso mediante la scelta di interrompere il circuito. Il primo passo è rendersi conto che un circuito c’è ed è perverso, provoca dolore, approfondisce la disistima personale, aumenta le difficoltà di un rapporto positivo e costruttivo con se stessi. Nel tempo diventa inevitabile la mistificazione, che porta a coprire sempre di più la natura dei problemi e a spiegare o giustificare la propria infelicità attribuendola ad altri o alle circostanze esterne, senza mai ammettere la propria parte. Quanto sono responsabile del mio destino? I due termini sembrano inconciliabili: se c’è un destino, pare non possa esserci libertà, ma in ogni vita sono presenti entrambe le componenti e guai se non fosse così. Per poter avere una sofferenza autentica, che preluda a un cambiamento, inaugurando una possibilità nuova di essere (il che non implica alcuna garanzia circa il traguardo), c’è bisogno di passare attraverso l’assunzione di responsabilità, ciò significa scegliere di prendere atto seriamente di quanta violenza sia stata subita dagli altri e quanta praticata, dunque di quanto male sia piena l’esistenza e di quanto dipenda da noi. Per alcuni sarà necessario arrivare a chiedere un aiuto specifico, e alle persone giuste, per poter tentare una operazione di «correzione» delle deturpazioni accumulate. Ci sono ferite che non possono essere scoperte e curate da soli, c’è bisogno dell’aiuto di altri per farvi fronte. Quel che spetta a ciascuno è il desiderio di voler conoscere e di volersi dare delle opportunità di cambiamento attraverso la consapevolezza. Molti sono terrorizzati anche solo dall’idea di stare soli con se stessi, temendo di guardarsi dentro e di scoprirsi «mostruosi». Usano gli altri alla stregua di specchi, ma di fatto specchi fatti solo di cornice (come in un dramma di Ibsen). Si specchiano e vedono ciò che già sanno di sé oppure quello che sospettano o ritengono sia la loro «natura» nascosta. Non si tratta di un vero specchio, infatti non c’è conoscenza e neppure dinamica, c’è solo una cornice rassicurante e consolatoria anche quando è negativa e fa dire: «ah sono proprio un mostro, un disgraziato, una vittima». Si chiude così il cerchio in senso narcisistico e non è possibile alcuna evoluzione. Il lamento sulla propria infelicità produce ben poco, ci si può lamentare tutta la vita delle proprie disgrazie senza che si faccia un solo passo avanti per uscirne, perché non ci si prende mai sul serio. Prendersi sul serio vuol dire che una volta capito non si torna più indietro, la via del ritorno è impraticabile, le porte sono sprangate. Tante persone fingono di abitare nella parte della casa visibile dall’esterno, mentre mantengono aperta o socchiusa una porta sul retro che non vogliono murare e di cui non vogliono fare a meno. È la via di fuga dalla realtà, dalla responsabilità, dall’essere dentro la vita come tutti gli altri: mortali come tutti gli altri, rinunciando all’onnipotenza. Poiché conservano sempre tale possibilità di scappare, si privano di una vita autentica e di una casa propria. A volte sembra realizzarsi un apparente rigoglio, ma basta poco perché ci sia un crollo, un disseccamento della pianta, perché non ci sono radici e vengono sfruttate quelle altrui. Se non si entra in contatto con la terra, non si possono mettere radici. Se non si vuole entrare fino in fondo nella vita e si cerca di aggrapparsi ad entità esterne, l’unica possibilità di sopravvivenza è il parassitarismo. Si tenta allora di sfruttare le risorse e persino i limiti altrui, di trapiantarsi e di fare un innesto su un’altra pianta. Non c’è vita autentica, se non si poggiano i piedi per terra nella realtà e se non si accetta di pagare in prima persona responsabilmente. Si potrebbe dire che molte esistenze non sono altro che un pagamento continuo, però con soldi presi in prestito e per conti non esistenziali. Si constata, cioè, una facilità a procurarsi danni, a passare attraverso l’inferno accumulando fallimenti su fallimenti con una leggerezza sorprendente. Pare che non ci siano ferite e cicatrici, perché si è di fronte a soggetti e corpi invulnerabili sostenuti dall’onnipotenza. Al posto dell’identità c’è un pallone gonfiato, che vola nonostante il cattivo tempo e l’assenza di vento, e che si fa fatica a trattenere al suolo. Mettere i piedi per terra può portare a scoprire che forse le radici sono putrescenti, mancanti, o tagliate; una privazione può aver compromesso la personalità e non si potrà evitare un lavoro di risanamento o di bonifica, poiché sulle sabbie mobili non si costruisce. Ognuno ha una storia molto precisa da cui non può uscire mai completamente, potendo soltanto cercare di viverla con realismo utilizzando il più possibile quel che c’è e non quel che non c’è. Per le ferite d’amore, per esempio, la comprensione non comporta la sparizione delle cicatrici. Quella ferita rimane, non viene compensata, neanche da una terapia psicologica, che semmai porta ad un rapporto diverso con la ferita e con la coscienza di se stessi, promuovendo un cambiamento al posto della ripetizione. Dietro l’ignoranza del male c’è un atteggiamento violento nei confronti di se stessi e degli altri; per questo l’incapacità di amare o di amare con creatività, dando libertà agli altri, è anche l’incapacità di dare libertà a se stessi. Si tratta di accettare di investire in progetti senza garanzie, percorsi che non si imparano in qualche seminario, e neppure nel corso di anni perché ci vuole tutta la vita. E non c’è via d’uscita, non c’è promessa di salvezza, ci si deve accontentare di sapere di essere incamminati verso il centro e non verso la periferia. Troppi vogliono e chiedono un benessere esteriore, che equivale a vivere alla periferia di se stessi; sono terrorizzati dal centro, da ciò che c’è e potrebbe esserci nella parte centrale della personalità, il vuoto, l’angoscia, la violenza, il terrore, i mostri che si annidano in tali profondità, perciò si spostano verso la periferia, oppure la superficie, dipende da quale prospettiva si usa. Si collocano e agiscono sul piano periferico ricorrendo molto al contatto con gli altri (fisico, sessuale, materiale) e cercando la fusione, la concreta e tangibile vicinanza. Sembrano intrattenere molte relazioni e avere molti punti di contatto con gli altri; eppure, se non si può contare su di un centro organizzatore dell’esistenza, è impossibile una reale intimità interpersonale. Quando si vive troppo alla periferia di se stessi è perché il centro condiziona in maniera autoritaria e inconsapevole, attraverso l’emotività e i bisogni. I conflitti di cui non si è consapevoli continuano a condizionare tutti i gesti, sicché si crede di essere liberi proprio mentre si è schiavi fino all’ultimo dettaglio, anche nella trasgressione. Il benessere estetico socialmente approvato approfondisce il problema perché fa ritenere superfluo il benessere etico, cioè il «ben essere», il rapporto che la persona ha con se stessa su un piano etico. La rinuncia alla dimensione etica e culturale della sessualità spinge a cercare grandi emozioni e grandi entusiasmi sensoriali, veri e propri bombardamenti emotivi, allo scopo di amplificare la sensazione di essere vivi. A conti fatti c’è un difetto centrale di vitalità che si cerca di compensare con un aumento dell’intensità dei contatti e degli stimoli che vengono dalla periferia. Ciò che si vuole scongiurare è il cadere nell’angoscia e nella violenza di cui si è pieni e da cui si è terrorizzati. Non si è colpevoli di questo stato di cose, ma senza un riconoscimento di responsabilità non c’è possibilità di libertà. Il male è appeso alla libertà, non solo alla necessità. Se ci fa orrore, è proprio perché possiamo ipotizzare che potrebbe non esserci, poiché se fossimo convinti che c’è in assoluto, senza alcuno scampo, non ci susciterebbe tanto orrore. Non è un caso che oggi non ci si spaventi più di niente, che quasi nessuno provi più orrore di fronte al male dell’uomo sull’uomo a cui tutti si sentono autorizzati. Essere consapevoli della propria natura e di quale sia il patrimonio di distruttività e di aggressività che ci si porta dietro è necessario per poter tentare un processo di trasformazione e non per legittimarsi. Quante volte la conoscenza di queste verità sembra essere una sorta di legittimazione dell’egoismo più spietato e arrogante (“ho bisogno di qualcosa, la prendo; sento degli stimoli, devo assecondarli”)?! Gli altri non servono se non a reggere uno specchio o a fungere da strumenti. Ogni qualvolta l’altro manca quale interlocutore o non gli è consentito di svolgere tale ruolo, siamo noi ad impoverirci e a trovarci ridotti sempre più al narcisismo, ad una specie di autocrazia in cui alla fine noi siamo al centro e tutto il resto è contorno; il che riproduce nella vita adulta una situazione di tipo «infantile», per cui pare che il mondo esista per noi invece del contrario. A quel punto si cerca di soddisfare quelle che sembrano esigenze personali e che non sono neppure veri interessi bensì solo appetiti, perché gli interessi presuppongono l’autocoscienza e la scelta. Un adulto dovrebbe poter essere in grado di contrattare, non in senso fiscale bensì secondo una logica umana, cosa intenda fare nella sua vita sessuale, a quali condizioni stabilire dei rapporti, con quale grado di comunicatività; dovrebbe sapere in anticipo che per avere certe cose dovrà darne in cambio delle altre, valutare il prezzo in termini emotivi o di sensi di colpa, per esempio, se decide di mettere in atto alcuni tipi di condotta. Non può ragionare nella logica del "pentimento" di chi prima commette peccati e poi cerca la assoluzione o la punizione per rendere nullo il gesto compiuto e ritornare al punto di partenza, senza mai scegliere le azioni da compiere. Spesso vengono spese nella vita di relazione parti di sé che sono dei rami secchi senza speranza di fioritura, mentre magari altre vengono private di attenzione, lasciate incolte e incomprese. La sessualità di un adulto dovrebbe essere propria, cioè suo canale di espressione e creatività. Essendo in gioco una parte molto importante della realizzazione, si dovrebbe pensare nell’ottica di un investimento attivo e proficuo. Quanti invece pretendono di essere amati senza rendersi amabili! Quanti non si amano, non si accettano, hanno su di sé solo convinzioni negative, eppure pretendono che gli altri compensino questa mancanza di amore o dimostrino loro che sono amabili, senza dover fare il minimo passo in quella direzione e senza mai prevedere reciprocità o scambio. Volere amare o volere essere amati non significa volere una relazione con l’altro; si tratta semplicemente di una esigenza legittima ma insufficiente per sostenere la vicinanza con un’altra persona in carne ed ossa, alla quale riconoscere un narcisismo almeno pari al proprio. Non bastano buoni propositi. Molti pretendono la gratificazione di un bisogno e la compensazione o il risarcimento di un affetto che non provano per se stessi o che non vogliono provare; se questo è vero occorrerà darsi da fare per rendersi amabili e per consentirsi esperienze più positive. Sarà un lavoro che richiederà magari dieci anni, anche se non se ne hanno a disposizione così tanti, ma non importa. L’importante è andare nella direzione giusta, quella che porta al centro di se stessi, per poter prestare cure e attenzione alle proprie ferite. È una scelta di coscienza e di autonomia, perché si decide di cominciare da sé a realizzare l’operazione di ricostruzione di un senso e di riconciliazione. Quando siamo incapaci di amicizia o addirittura abbiamo un nemico interiore, un rapporto persecutorio con noi stessi, è assurdo pretendere di poter avere relazioni amicali, cioè che dall’esterno provengano quelle dimostrazioni di affetto, di stima e di riconoscimento che poi in effetti non si è in grado né di contraccambiare né di vivere in prima persona. È difficile accettarsi con tutti i limiti, le miserie e le povertà presenti in tante aree della propria personalità o con tutte le privazioni della propria storia. Non è facile fare i conti con il destino personale. Per quanti sforzi si facciano, si resta in una prigione, che non può essere mai del tutto abbandonata; si può dipingerla d’oro e decorarla, non uscirne. Riconoscere la prigione è tragico, significa prendere coscienza di quel che davvero si può fare rinunciando alle fantasticherie. Si può costruire qualcosa solo a partire da quel che c’è nella realtà, dalla propria autentica condizione. Il disprezzo e la mancanza di stima personale si riverberano nelle relazioni e non potrebbe essere altrimenti. Non si diventa migliori affidandosi a fantasie di grandezza e di salvezza. C’è chi auspica una giustizia retributiva, in base alla quale chi non ha avuto dovrebbe avere; al contrario, di frequente a chi non ha viene tolto anche quello che ha... È il rapporto con se stessi quindi la variabile su cui poter intervenire per produrre dei cambiamenti. Vanno perciò abbandonate tutte le illusioni riguardo alle relazioni sentimentali e le aspettative gratuite di gratificazione. Jeanette Winterson nel romanzo Non ci sono solo le arance mette in guardia ironicamente contro le insidie del sentimento riferendo un gustoso episodio paradigmatico. La madre della protagonista racconta di essersi lasciata andare al primo amore in virtù del grande fermento interiore provato nei primi incontri. Recandosi in seguito dal medico aveva scoperto di essere affetta da un’ulcera, e allora la morale è: « a volte quel che credi sia il cuore potrebbe rivelarsi in realtà un altro organo ». La gran parte delle persone è convinta che i sentimenti provati siano comunque espressione della dimensione affettiva e della parte migliore di sé. Certo, ciascuno è in via di principio dotato di propensione all’amore, come possibilità e non capacità già data. Tanto che in certe situazioni l’amore bisogna cercarlo al microscopio, a meno che non si accetti di chiamare in tal modo il sentimentalismo a buon mercato. È importante capire da quale organo partano il sentimento, l’entusiasmo, l’emozione, nonché di cosa si abbia effettivamente bisogno. Altrimenti si costruiscono rapporti che rischiano di approfondire il solco del vuoto e delle difficoltà, perché si scelgono le persone sbagliate per la propria evoluzione, benché giuste per il proprio difetto. Ne viene confermato il circuito perverso, perché sono partner appropriati da punto di vista della malattia e non dal punto di vista della potenziale salute e del cambiamento. Altre volte si individuano le persone «giuste», ma poi si distruggono le opportunità di collaborazione per una vita migliore. Si scopre allora che, nonostante il gran parlare di infelicità, la felicità è vietata, il soggetto può vivere la felicità solo idealisticamente in alcuni castelli creati ad arte. In ogni caso, anche quando va bene o benissimo, le ferite non vengono «compensate». Lo esprime con grazia Federico Garcia Lorca nella poesia Verso : « e dirai amore, amore! / senza che la tua ferita/ si risani ». Le ferite non verranno mai guarite, eppure è importante conoscerle, perché altrimenti se ne è condizionati solo in modo negativo, mentre, grazie alla consapevolezza, si può sperare di organizzare un lavoro di crescita, di accompagnamento affettivo per se stessi verso altri tipi di esperienze, più umane nel senso positivo del termine. L’aspirazione al benessere etico o ad un buon rapporto con se stessi dà soddisfazione e si traduce in relazioni migliori. La stima per me stesso ingloba gli altri, perché ogni mia esperienza è qualcosa ch’io intendo valorizzare, facendone un uso costruttivo e non distruttivo, che mi elevi e non mi degradi. A livello interpersonale l’attribuzione di credito e stima dipende dal grado di autostima. La disistima personale porta anche alla disistima dell’altro, come chi teme di essere disprezzato spesso ritiene di doverlo essere. Nessuno per certi aspetti sa meglio di noi quali siano le nostre nefandezze e le nostre miserie, perciò si può temere che vengano colte dagli altri nell’avvicinamento al nostro territorio. È opportuno partire dall’idea che anche l’altro sia potenzialmente capace di autostima e di responsabilità. Se sono il primo interlocutore di me stesso, è più facile che cerchi nell’altro un interlocutore adeguato, quindi che lo ponga ad una certa distanza, su un piano diverso da quello delle manipolazioni e dell’uso distruttivo. La distanza non è la freddezza della lontananza siderale, in cui è impossibile ogni forma di contatto; piuttosto è quello spazio connaturato al confronto tra due identità sufficientemente distinte pur se non del tutto definite. Le identità constano di una parte fissa, che rimane stabile nel tempo, e di una parte che, grazie alla flessibilità, resta mutevole e dinamica, altrimenti c’è il rischio della fossilizzazione e della mummificazione. Una componente deve restare costante come segno della distinzione dell’individuo, l’altra deve essere aperta ai cambiamenti per poter evolvere e migliorare. La consapevolezza di sé per entrare in intimità con le altre persone è un requisito fondamentale. È inutile concentrarsi su esperienze di risveglio fisico o sensuale, corsi di bioenergetica e simili. Solo se si mettono in gioco le periferie collegate ad un centro se ne potrà ricavare un vero beneficio. Abbiamo bisogno di piacere corporale nell’esistenza, perché non siamo scissi, bensì un insieme di elementi fisici, psicologici, emozionali, culturali e spirituali, e siamo vivi solo mediante il corpo. Non c’è niente, tuttavia, di più consolante, del sapere di essere dentro se stessi, cioè di abitare e avere una casa al proprio interno. Si può essere confortati dagli abbracci altrui, dalla tenerezza fisica e dalla fusione sessuale, ma abitare la propria interiorità e potere dimorare nella più profonda intimità è senz’altro una delle esperienze più rassicuranti che esistano. Quando il ruolo svolto dal corpo e la sua possibilità di trarre piacere dall’esistenza si ridimensionano per forza e drasticamente, chi si è concentrato molto nelle proprie periferie si trova enormemente svantaggiato poiché non gli è più possibile un’identificazione positiva con se stesso. Chi si è dato molto da fare per il narcisismo esteriore, appena perde il treno della salute apparente e materiale rischia la disintegrazione, perché il suo nucleo interiore è fragile, denutrito, oppure pieno di angosce o cose sgradevoli. Non poter restare soli con se stessi è un grande svantaggio nella malattia, non nel senso dell’autosufficienza fisica ma nel senso dell’opportunità di guardare verso l’interno e farsi compagnia, prendendosi cura delle piccolezze e dei limiti, comprendo gesti di accettazione che riguardano le ferite. Tale compagnia è ben diversa dal rigirare il coltello nella piaga dei tanti che nelle delusioni sentimentali e nelle sventure alzano un lamento sterile, per coprire la non volontà di apprendere da quel che si è vissuto, con la scusa dell’assenza di prospettive e di garanzie. Diventare capaci di passare dagli appetiti agli interessi e volere integrare la propria sessualità comportano l’accettazione del pagamento dovuto e naturale per ottenere la soddisfazione. Sicché, la questione è diventare capaci di (re)stare nella realtà. Illudersi di essere normali non annulla la condizione oggettiva di fondo, l’unica base sulla quale sia possibile costruire una relazione; se no, si gettano ponti che non esistono invitando gli altri a passarci sopra. I ponti vanno costruiti e voluti, presuppongono un impegno molto duro, comportano sofferenza, non c’è altra strada e persino l’idea della colpa può essere utile. Pensiamo al romanzo di Nathaniel Hawthorne La lettera scarlatta, in cui la protagonista deve portare sul petto una lettera "A" come condanna per l’adulterio. Passando attraverso solitudine, vergogna, disperazione, ella arriva a coltivare una possibilità di essere e di ricostruire l’esistenza che invece è negata all’amante ipocrita e pavido, via via consumato da una colpa nascosta. Il trauma può diventare un fattore di identificazione, un elemento di ri-strutturazione in quanto "centro". Persino l’Aids finisce per rappresentare un’opportunità di identità anche laddove non ce n’è mai stata una, offrendo un centro organizzatore, grazie al quale mettere ordine e ripartire. Succede nei casi fortunati, per cui nell’individuo, che non aveva mai avuto una bussola, avendo vissuto letteralmente allo sbando in un’esistenza non propria, improvvisamente, attraverso la scoperta della malattia e la presa di coscienza, comincia a prender forma un centro e in rapporto ad esso una forza di gravità e un pianeta. La mancanza di un centro impedisce la progettazione e la programmazione, nonché l’assunzione di responsabilità. Per questo le identità sono molto importanti, identità fondate su aspetti determinanti della propria vita, ed è per questo che rifiutando di riconoscere la propria diversità, molti si privano dell’unica occasione a disposizione per elaborare un progetto e costruire in relazione ad un centro forte. È necessario sviluppare la capacità di soffrire in funzione di uno scopo utilizzando la sofferenza per la propria realizzazione. Per certi aspetti si può dire che non è mai tardi, che si può cominciare a vedere anche quando si diventa ciechi. Si tratta di scegliere di essere dentro la realtà e di riconoscersi per quello che si è. Applicarsi alla generazione della propria identità è un lavoro vero e proprio, a cui bisogna dedicare tempo, sottraendolo ad esperienze di divertimento e di svago. Orientarsi verso la propria centralità, l’identità di persona, per tentare di risanare quel che è possibile o soltanto di capirlo, è una decisione importante e di per sé salvifica. Raccontarsi la propria storia, fare attenzione a quello che si è vissuto è a volte il solo gesto che la persona può fare per uscire dal circolo vizioso del male. L’amore buono è quello che promuove il nostro valore e ci protegge dai nostri stessi attacchi. Esso produce un’opera di purificazione e chiarificazione dell’oscura nebbia negativa che circonda l’essere. Può accadere nelle relazioni terapeutiche di aiuto, in cui chi è accanto fa un’operazione pregiudizialmente positiva di amore nei confronti dell’altro, lo ritiene capace di bontà e lo aiuta a liberarsi dalle sue critiche distruttive. Si creano così condizioni per sperimentare una possibilità di amare se stessi e quindi di rivolgersi agli altri con atteggiamenti più costruttivi e positivi, superando la posizione di attesa passiva della gratificazione sentimentale e sessuale. Per realizzare concretamente tale progetto ciascuno deve riuscire a individuare gli interlocutori giusti, le strategie più opportune, persino i contesti adatti. Le risorse sono spesso più vicine di quanto si creda, basta valorizzare e dare consistenza ai rapporti esistenti in quanto occasione di conoscenza e di arricchimento. L’identità è una scelta di auto-riconoscimento, nella quale si decide di avere con se stessi un rapporto particolare e si fa del desiderio di cambiare un vero catalizzatore dell’intero potenziale di desiderio, qualcosa di voluto intensamente come una forma di libertà. È la liberazione dalla schiavitù di un destino solo negativo o di un passato pieno di fallimenti, dall’impossibilità di sorprendere se stessi, di stupirsi con dei gesti mai fatti, con cose mai dette, con azioni impensabili in precedenza, entrando così nella dimensione della possibilità. Niente di nuovo è davvero possibile, se non c’è il senso della realtà. Con la realtà oggettiva bisogna seriamente fare i conti perché tutto quello che si costruisce al di fuori di essa prima o poi svanisce, crolla a terra rovinosamente, anche dopo anni; ogni identità edificata sull’apparenza e sull’immagine ideale di sé è destinata al fallimento. La gran parte delle persone ha paura di star dentro la realtà, la ritiene solo punitiva e non riesce ad accontentarsene. Chi possiede il senso della realtà ha anche il senso della possibilità e può diventare creativo, ovviamente in grado diverso per ciascuno, perché esistono differenze notevoli e inevitabili di dotazione e talento. Nel contesto della malattia e del disagio è importante fare distinzioni per capire quale esperienza potrebbe essere più produttiva per uno specifico soggetto, di quale sofferenza avrebbe bisogno, quella sofferenza che consente di arrivare al cuore di se stessi e di prendersi sul serio. Come si può avere a cuore la vita degli altri quando non si riesce neanche ad avere a cuore la propria? Anche coloro che passano sopra a se stessi per il bene degli altri, si illudono di poter soprassedere sulla questione del valore reale della propria vita, del suo prezzo e del costo dell’amore. Vivere in maniera dignitosa coltivando una relazione positiva con se stessi e il mondo è un impegno oneroso. Il tempo da destinare a se stessi non può essere speso in altri modi, va dedicato esclusivamente alla conoscenza venendo a patti con i fantasmi personali, arrivando a confrontarsi con l’uomo sotteso al personaggio magari tanto affabile e seduttivo. Se temo di fare sul serio con me stesso, cercherò sempre di evitare che lo possano fare gli altri. Sono autentici solo i rapporti tra persone che scelgono e accettano di essere presenti onestamente e in modo realistico. Molti non hanno rapporti personali perché non ci sono, al loro posto c’è una contro-figura, l’attore su cui hanno investito enormi energie nel corso del loro presunto sviluppo. L’amore non può essere dato per scontato, ha bisogno di essere dimostrato in ogni caso, mettendo in discussione tutta la mitologia e i luoghi comuni sul sentimento. Bisogna chiedersi se una relazione possa migliorare la vita oppure no, perché l’alibi del «ti amo da morire» conduce ad accettare vincoli degradanti fondati sul martirio o sul sadomasochismo morale. Quel male d’amore di fatto non costa niente perché già previsto nel copione, non ha un prezzo esistenziale vero perché è soltanto il riciclaggio di un dolore scaduto, quindi l’individuo era già sacrificato precedentemente una volta per tutte. I dettagli concreti della vita sessuale, le precauzioni, quel che si è disposti a fare nel sesso, sono tutte cose secondarie: quando la persona è diventata capace di fare una scelta, allora agirà anche di conseguenza da questo punto di vista. Non c’è bisogno di mostrare la propria disponibilità, il proprio interesse per il partner con delle concessioni nella pratica sessuale, per esempio: non saranno i millimetri del profilattico ad impedire la vicinanza di due persone, o la fusione esistenziale e psicologica. C’è bisogno del coraggio di guardarsi dentro, di guardarsi in faccia e di guardare anche gli altri con uno sguardo a cui non ci si può sottrarre, che inchioda letteralmente alle pareti, per riconoscersi davvero come esseri umani, con tutto ciò che sappiamo sulla umanità. Questa consapevolezza reale è ciò che consente di costruire qualcosa di buono pur senza garanzie di successo o di immortalità. Dobbiamo giungere a coniugare responsabilità e destino. Chi non accetta la responsabilità preferisce pensare che niente dipenda da lui. Chi enfatizza la responsabilità la trasforma in una forma di onnipotenza credendo di essere l’unico padrone del proprio destino, quindi alla fine si mette al posto di Dio: « sono l’unica causa di me stesso, tutto dipende da me ». Guardando dall’alto ciascuno di noi è insignificante, ma guardando dal basso ogni individuo ha la sua importanza, ogni vita rivela un progetto che nel tempo diventa sempre più evidente. Nei rapporti interpersonali si mette in atto il tentativo di guarire da alcune sofferenze, naturalmente con gli strumenti a disposizione e quindi magari riuscendo solo a procurarsi ulteriori patimenti, soprattutto nel tentativo di difendersi dal dolore già provato. Rendersi conto di tale progetto è già il primo passo per capire la quota di responsabilità residua per intervenire consapevolmente. In alcuni casi la nostra parte può apparirci piccolissima, i nostri sforzi una goccia nel mare, un’impresa titanica e alla fine vana, eppure da un gesto anche minimo può dipendere la trasformazione dell’intero significato dell’esistenza. Se il destino esiste vuol dire che qualcosa ci sovrasta e non possiamo che subire; ma esiste la possibilità di essere responsabili, allora abbiamo un ruolo. Ciascuno di noi ha una «potenza», che è la sua risorsa, il suo potenziale umano; il potere è l’organizzazione di tale potenza. Anche l’essere più insignificante, anche la vittima per eccellenza ha un po’ di potere sulla propria esistenza, una responsabilità che non viene meno anche quando è rifiutata o evitata. Molti per sfuggire alla sensazione dell’impotenza e alla coscienza della responsabilità alzano un grande polverone di cose negative (trasgressioni e fallimenti), che possono essere ricondotte alla loro «cattiva volontà» e quindi sembrano dipendere da loro. Dietro l’ebbrezza di tanta onnipotenza negativa si nasconde il tentativo di negare quanto potrebbe derivare dall’assunzione della responsabilità di dare alla vita un orientamento costruttivo. La responsabilità è pur sempre parziale e limitata, riguarda sempre quel poco alla nostra portata. A maggior ragione, invece di disperarsi per quello che non si può fare, bisognerebbe concentrarsi su quello che si può fare di buono. Troppi, infatti, si rovinano la vita pur di non venire a patti con i limiti, accumulando limitazioni e invalidità. Troppi consumano la vita girando a vuoto nell’illusione di fermare il tempo; così muoiono per non morire. Mattia Morretta (1996) Testo originale in Sessualità e Aids: dal limite alla creatività, A77 Milano
