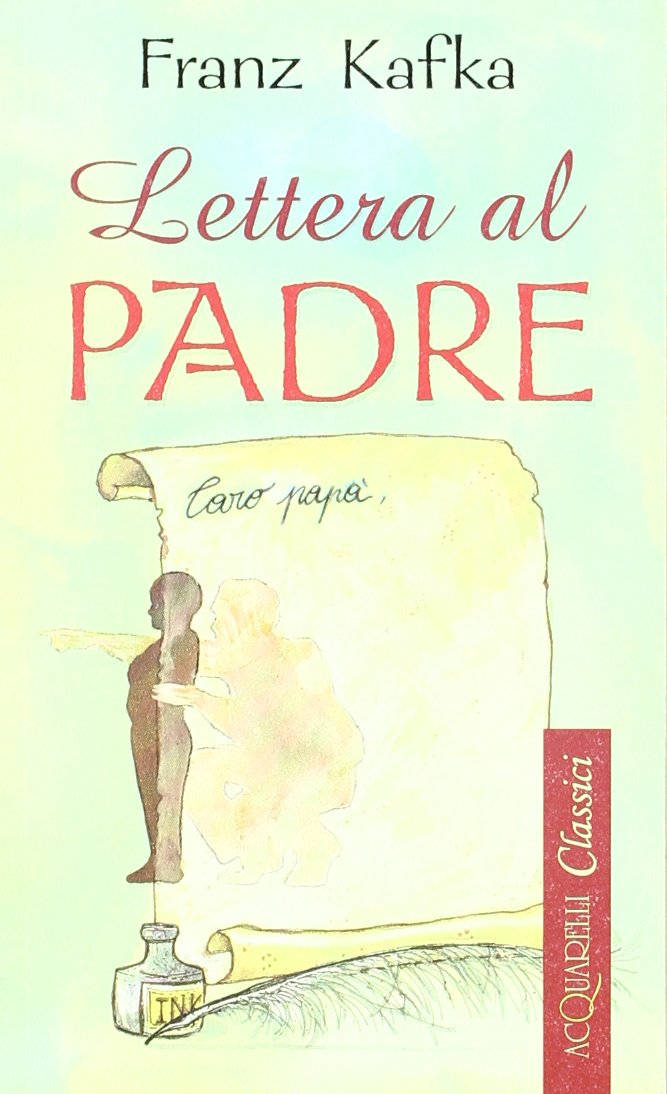La personalità secondo Kafka
La via spirituale di Giuni Russo
11 Novembre 2024La libertà in amore
17 Gennaio 2025
Kafka e il diritto alla personalità A cento anni dalla morte il richiamo morale del grande scrittore boemo sulla famiglia e l’educazione, maturato nel privato di un giovane fragile e immaginifico
• Umbria Green MagazineUna testimonianza di indubbio valore per la comprensione della figura di Franz Kafka (3 luglio 1883 - 3 giugno 1924) è la cosiddetta Lettera al padre. Scritta nel novembre del 1919, a trentasei anni, mai consegnata al destinatario (per interposizione della madre), è stata resa nota solo dopo il secondo conflitto mondiale, perché era stata affidata all’amico Max Brod con la preghiera di bruciarla.
Da lui stesso definita “chilometrica” e “da avvocato” (centoquattro pagine, ventisei fogli di protocollo), trascrizione di una minuta non conservata, il manoscritto pubblicato nel 1986 comincia con “Carissimo papà, recentemente mi hai chiesto perché sostengo di aver paura di te”, che nel dattiloscritto diventa “Caro papà”. Un sofferto memoriale della dipendenza filiale quando il genitore era già vecchio e infermo, eppure percepito ancora come l’omone insensibile, oppressivo e distanziante della sua adolescenza.
Hermann Kafka discendeva da un macellaio kashèr e aveva vissuto in grande povertà, patendo la fame e la promiscuità (otto persone in un locale), costretto da bambino a tirare il carretto di villaggio in villaggio, le gambe piagate per mancanza di vestiti. Ciò nonostante era riuscito a diventare comandante di un plotone nell’esercito austriaco (conservandone la mentalità militare, tanto da far marciare i figli) e in seguito a far carriera come commerciante e industriale a Praga. Franz ne era l’ombra, schivo e irresoluto, scapolo e sino ai trent’anni nella casa di origine, 55 kg di peso netto, laureato in legge con la sufficienza, quindi addetto a un semplice impiego (“l’impiegato profondamente radicato in me”) con avanzamento al ruolo di revisore dei conti, su misura per lui che teneva il registro delle mortificazioni.
Il padre è il tipico caso di autoritarismo ingessato, uno di quegli uomini chiassosi e plateali nella rappresentazione del comando, che danno ordini e non consigli, non sopportano che i figli maschi vivano meglio e vi proiettano i vissuti che tengono sotto controllo in sé stessi (passività, debolezza, inadeguatezza). Hermann rinfaccia infatti a Franz di fare “la bella vita” (disponendo di una camera tutta sua), libero di studiare e di non guadagnarsi il pane, per giunta indisponibile a collaborare nell’impresa di famiglia, il negozio di “galanterie” (grembiuli, biancheria, pantofole) poi sostituito dall’azienda di produzione dell’amianto.
Il potere paterno di condannare e sminuire alla cieca incide nel fisico e nello spirito del figlio profonde cicatrici, ben diverse da quelle esistenziali utili alla consapevolezza. Lo scrittore ricorda un episodio dei primi anni, quando, in risposta al suo piagnucolare per avere dell’acqua di notte, era stato preso di peso dal letto e lasciato in camicia sul ballatoio davanti alla porta chiusa.
Sentendosi senza scampo (“non sono mai sfuggito alla presa”) Franz annega in uno smisurato senso di colpa, alimentato dalla vergogna per il proprio comportamento nel clima di costante processo. Col tempo dà ragione al genitore circa l’inettitudine e l’insuccesso, ma è un modo paradossale di avere un babbo tutto per sé e appartenergli in senso velatamente libidico (piange anche mentre scrive la missiva). Afferma che avrebbe potuto accettarlo in qualità di amico, capo, zio, nonno o suocero, ma come padre era “troppo forte”; e lamenta di averne subito il pieno impatto perché i due fratelli minori erano deceduti presto e le tre sorelle erano nate assai più tardi.
Non c’era stata tra loro “vera lotta”, il papà tutto forza e salute, voce tonante, tentato di schiacciare i subalterni senza lasciarne traccia, aveva avuto buon gioco a “liquidarlo”. Perciò da grande il figlio contesta il rimprovero paterno di essersi arreso, poiché non gli aveva lasciato alternative pretendendo che fosse qualcosa che non era e non poteva diventare. Il genitore lo voleva forte e coraggioso, lo approvava a condizione che marciasse e cantasse canzoni di guerra facendo il saluto militare, nonché si alimentasse a sazietà e bevesse birra. Le sue lezioni concernevano soprattutto il comportamento a tavola durante il pasto comune, accompagnato da ingiurie e sberleffi.
Per esempio, intanto che mangiava affamato e in fretta, a grossi bocconi fumanti, rimproverava a lui il proprio atteggiamento: “Sei davvero un porco”. La risposta di Franz allora era isolarsi e rintanarsi in camera, per percorrere l’unica via aperta, quella intellettuale, e crescere almeno in statura letteraria. A furia di udire “non voglio sentire obiezioni”, aveva preso a incespicare e balbettare, taceva e si allontanava da tutto ciò che era associato al papà (negozio e ditta), accettando quel che veniva dalle sue mani come un mendicante e avvertendo una labile affinità col clan materno. Non era d’aiuto il fatto che la madre ai suoi occhi avesse una insufficiente “forza spirituale autonoma” e tendesse a “viziarlo”.
Acutamente Kafka osserva che c’è differenza tra affrontare la lotta quotidiana per la vita da subito (in condizioni di ristrettezze) e farlo tardi, “in età adulta ma con forze infantili”, entrambe situazioni svantaggiose però con esiti diversi nella maturazione. Dice nella Lettera: “Non tutti i bambini hanno la costanza e il coraggio di cercare sino a quando non trovano la bontà”. E rammenta il terrore di dover assistere alle scenate del papà urlante col volto paonazzo, le bretelle slacciate in fretta e poggiate sullo schienale della sedia, tanto da fare il paragone con chi sta per essere impiccato e deve partecipare a tutti i preparativi, apprendendo di essere graziato quando già il cappio penzola davanti alla faccia. La minaccia “ti straccio come un pesce” si associava in lui a una sorta di rammarico, perché in realtà non veniva toccato “nemmeno con un dito” e l’intangibilità siglava l’irriducibile estraneità psicofisica.
Il figlio, percependo la volontà del genitore di imporsi, dando addosso pure al personale del loro negozio, si appiattisce e si schiera con i sottoposti maltrattati, finendo per approdare alla scrivania di impiegato in un Istituto delle Assicurazioni per infortuni. Si paragona al verme pestato da un piede che si trascina di lato con la parte sopravvissuta, è portato a “umiliarsi” e “strisciare”, “infantilmente inerme”, sentendo risuonare nelle orecchie il vocabolo “schifo”, uno dei preferiti dal babbo.
Se è inevitabile pensare ai temi ricorrenti delle sue opere (su tutte La Metamorfosi), è l’autore a confessarne l’ispirazione: “I miei scritti riguardavano te, vi sfogavo solo quanto non riuscivo a sfogare sul tuo petto. Era un congedo da te che procrastinavo di proposito”. Solo mediante la scrittura gli è possibile dimostrare di esserci e valere, perciò ritiene suo dovere vegliare e proteggere lo scrivere da ogni pericolo, incluso il matrimonio. Per ripicca il papà, quando lui portava a casa una sua opera pubblicata, diceva, senza smettere di giocare a carte, “mettilo sul comodino!”.
Il sentirsi rinfacciare di vivere alle spalle del capofamiglia e l’ascoltare i commenti astiosi in presenza di sconosciuti (“le faccende dei tuoi figli erano sempre pubbliche”), avevano tracciato veri solchi nel cervello del ragazzo, sovrastato da “un sentimento di nullità”, favorendo un’immaginazione gelida e la disaffezione dal corpo. Allora trascorreva gran parte del tempo poltrendo sul divano o sdraiato in camera, reagiva dentro ma non agiva: “Da quando ho l’uso della ragione ho dovuto preoccuparmi a tal punto di difendere la mia esistenza spirituale che tutto il resto mi è stato indifferente”.
Nei Diari (12 novembre 1914) scrive: “I genitori che dai figli si aspettano gratitudine (ci sono persino quelli che la pretendono) sono come usurai, rischiano volentieri il capitale per incassare gli interessi”. E in una lettera a Carl Bauer (28 agosto 1913): “Vivo tra ottime persone, amorevolissime, più estraneo di un estraneo. Con mia madre negli ultimi anni non ho scambiato in media più di venti parole al giorno, con mio padre poco altro che il saluto. Con le mie sorelle e con i cognati non parlo affatto pur non avendo nulla contro di loro. Per la famiglia mi manca ogni senso di appartenenza”.
In una missiva dell’autunno 1921 indirizzata a Elli, prima delle tre sorelle minori e sposata con tre bambini, fa un passo avanti esponendo le sue riflessioni sull’inadeguatezza e la franca dannosità dei comuni metodi pedagogici, sintetizzando il pensiero di Jonathan Swift in merito: “Fra tutte le persone, i genitori sono gli ultimi ai quali si deve affidare l’educazione dei figli”. Perché si tratta di “un unico organismo, per così dire una circolazione sanguigna”, un microcosmo complicatissimo e squilibrato che procede per spasmi. Un contesto basato su una sperequazione estrema per lunghi anni cruciali a causa della “strapotenza” dei genitori, che tolgono ai figli voce in capitolo sentendosi gli unici titolari del sistema.
L’educazione vera, continua Franz, è quella sociale perché ne fa una questione umana, mentre quella domestica ne fa un affare di famiglia. Nella società ogni individuo ha uno spazio e una possibilità di rovinarsi a modo suo, tra le mura di casa c’è posto solo per chi si adegua; altrimenti si viene maledetti o divorati, sul modello di Crono che mangia i figli, in fondo “il più onesto dei padri” in quanto pietoso riguardo al loro destino. Papà e mamma non sono liberi di fronte ai loro figli perché a parlare è il loro sangue e agiscono in base al puro egoismo, “il sentimento autentico che contraddistingue l’essere genitore”.
Lo scrittore rimarca con decisione il punto cruciale: “Il fatto è che i genitori provano solo l’amore animale, insensato, che si confonde con il figlio, mentre l’educatore ha rispetto del bambino”, il che è “incomparabilmente di più, anche se non dovesse concorrere l’amore”, essendo in discussione “il diritto alla personalità”. La lettera si conclude ricordando l’invito di Swift ad allontanare la prole dalla famiglia sino a quando non sussiste parità fisica e intellettuale.
Il che non significa che gli interessati non possano rappresentare una buona comunità formatrice per i figli altrui, perché nel rapporto educativo si mettono in moto riflessioni e consapevolezze, laddove nel possesso genitoriale il pensiero è bloccato dalla spinta a lasciare l’impronta nei sentimenti e nel vissuto dei discendenti.
Lo stesso padre di Franz con gli estranei poteva diventare cordiale, come un despota che si mostra benevolo fuori dai confini del suo paese, mentre nella sua cerchia di influenza grava sui congiunti con la massima intensità. Lo testimonia František Bašik, che aveva trascorso tre anni di apprendistato nel negozio dei Kafka, sottolineando il trattamento meno duro del consueto, anzi quasi di favore, essendo stato incaricato di dare lezioni di ceco al piccolo Franz e aggregato al nucleo famigliare durante un periodo di vacanza, lui cristiano tra ebrei.
Nella Lettera al padre, l’eterno ragazzo, oramai segnato dalla grave tubercolosi polmonare, proclama a più riprese di essersi via via assuefatto alla prigionia, al punto che il suo maggior desiderio non era evadere dal carcere domestico, bensì di farne una “residenza estiva”. Col tempo aveva finito per considerarsi un caso singolare e scandaloso, impermeabile a ogni altra influenza esterna durante il periodo delle scuole e degli studi, diventando un ebreo non sionista e non credente, escluso da ogni comunità supportante. D’altronde l’ebraismo paterno era minimale e di facciata, inadatto a venir trasmesso, semplice adesione incondizionata alle opinioni della classe sociale di appartenenza.
Anche nel Diario annota, per non dimenticarsene, che viene definito “un pessimo figlio” e che lui stesso non sopporterebbe un essere “così taciturno, tetro, scialbo, deperito”, quell’ombra di fanciullo che traspare dall’aspetto. Nella corrispondenza da Merano nel 1920 con l’amata Milena Jesenská (giovane scrittrice boema e sua traduttrice), tiene a dire che, a parte i capelli brizzolati, a trentotto anni il suo viso è mutato assai poco da quando ne aveva sei. E afferma di considerarla una sorta di regalo per la cresima, la cerimonia ebraica denominata Bar Mitzva che segna il passaggio di maturazione dei maschi.
Riferendosi alle condizioni sotto il tetto di famiglia ribadisce: “Uno combatte a Maratona, l’altro nella sala da pranzo, il dio della guerra e la dea della vittoria sono dappertutto”. Nella sua mente ancora persistevano immagini di crudeltà affidate alle pagine private: “L’animale strappa la frustra al padrone e frusta sé stesso per diventar padrone e non sa che però è soltanto una fantasia, prodotta da un nuovo nodo nella frusta del padrone”.
Eppure, al di là delle tristi vicissitudini private, è evidente che siamo di fronte al dramma di una sensibilità eccezionale in una mente superiore, capace di una precoce coscienza della generale condizione esistenziale, lanterna filosofica accesa nella nebbia e nell’oscurità di un mondo votato al materialismo. Infatti, quel profondo dolore, pagato senza sconti, continua ad aiutarci nella strenua lotta per trasformare l’insetto strisciante e orribile del degrado umano nell’agognato principe dell’onestà morale e intellettuale.
Mattia Morretta